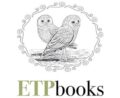Durante il dibattito sulla condanna a morte senza appello per i congiurati di Catilina, tra i pochi che intervengono a favore di una pena severa, ma rispettosa del diritto, è Gaio Giulio Cesare. Quasi quarantenne, il suo nome ha già incrociato più volte quello delle grandi figure politiche degli ultimi decenni. Sta ora per arrivare, però, il momento in cui Cesare entrerà nella storia in modo determinante.
Gaio Giulio Cesare apparteneva ad una delle famiglie più antiche di Roma, la gens Iulia, che si diceva discendente proprio da Iulo, figlio di Enea, a sua volta figlio della dea Venere, e che dunque poteva vantare fra i suoi antenati persino Romolo. Il cognomen Cesare derivava, secondo la maggior parte delle fonti, da un antenato che era stato fatto nascere eseguendo un’operazione sulla madre deceduta, un “taglio”, dal latino caedo, dunque una sorta di ‘parto cesareo’.
Nonostante questa antica nobiltà, la gens non era stata protagonista della storia della respublica, come altre grandi famiglie. Dai tempi del padre di Cesare, che si chiamava come lui, era probabilmente stata colpita da una crisi finanziaria. Cesare era nato nella Suburra, uno dei quartieri più popolari, nonché malfamati, di Roma. Il piccolo Gaio era comunque stato educato da un famoso precettore e aveva rivelato spiccate doti retoriche, grande passione per la storia e la politica. La situazione, mentre Cesare diveniva adolescente e poi giovane, non sembrava incoraggiare il suo futuro, e appariva anzi particolarmente sconfortante. Il ramo dei Cesari aveva sempre nutrito simpatie per la parte popolare. La zia Giulia, sorella del padre, aveva sposato Gaio Mario: ma quando Cesare stava per raggiungere la maggiore età, Mario, che pure era stato tra alterne vicende padrone di Roma, era morto. Nello stesso anno 86 a.C. era morto anche suo padre. Cesare, appena diciassettenne, aveva sposato, nell’84 a.C., Cornelia, la figlia del nuovo capo dei Mariani, Cinna. Ma dopo pochi mesi Cinna era stato assassinato e nel giro di due anni Silla aveva ripreso il controllo di Roma e di tutta la politica, anche attraverso una serie di feroci proscrizioni. Nelle stragi, peraltro, erano stati uccisi anche due zii di Cesare. Silla, preso il potere, aveva cercato di far divorziare Cesare da Cornelia, ma senza riuscirvi. Cesare si era rifugiato nelle campagne sabine: una volta, catturato dai soldati sillani, si era salvato corrompendoli con una somma di denaro. L’occasione per lasciare Roma gli era stata data dal pretore Marco Minucio, amico di famiglia, che lo aveva arruolato per una spedizione in Bitinia. Qui Cesare, ventenne, aveva conosciuto il re Nicomede III, amico dei Romani, che lo aveva ospitato a corte e, secondo le voci che erano iniziate a circolare subito dopo il suo ritorno a Roma, lo aveva colmato, nel segno della tradizione paideutica greca, di attenzioni e di affetto che Cesare non aveva rifiutato. In quell’occasione il giovane aveva avuto anche modo di mettere in luce il suo coraggio sul campo di battaglia: in un combattimento feroce aveva salvato la vita ad un superiore. Per le leggi volute proprio da Silla, un gesto simile gli aveva consentito di partecipare alle sedute del senato. Fu per questo motivo, dunque, che Cesare, pur non avendo ricoperto ancora alcuna carica politica, aveva potuto sedere tra i banchi del senato fin dagli anni settanta di quel secolo.
Tornato a Roma solo dopo la notizia della morte di Silla, Cesare fu informato, probabilmente, del tentativo di insurrezione di Marco Emilio Lepido, risolto nel sangue da Pompeo. Non entrò però direttamente nel piano di Lepido, e ciò gli salvò la vita. Iniziò dunque a dedicarsi a pieno regime all’attività forense, divenendo uno dei più apprezzati oratori del tempo. Il suo stile, dichiaratamente atticista, era condotto all’insegna di una sintassi ampia ma regolare: frasi parallele e coordinate, subordinate soprattutto esplicite e regolari. Anche nella grammatica Cesare apprezzava il cosiddetto analogismo: rifiutava le forme rare, arcaiche e difficili, e tendeva a regolarizzare declinazioni e coniugazioni. Questo stile, già all’epoca, corrispondeva alla sua personalità pacata e razionale, e anticipava quelli che sarebbero stati i suoi progetti politici chiari e precisi. Nel 76 a.C., intanto, nasceva la figlia Giulia.
Risale a questi anni un altro episodio rivelatore della personalità di Cesare: in un viaggio verso Rodi, ove si stava recando per perfezionare gli studi di greco, fu catturato dai pirati, che ne chiesero un riscatto di venti talenti. Cesare scoppiò a ridere, affermando che ne valeva almeno cinquanta: e così fece consegnare dai suoi amici tale somma ai pirati. Appena liberato, però, con l’aiuto di Nicomede, attaccò la loro base, si riappropriò del riscatto e li fece giustiziare, non senza regolare processo.
Nel 73 a.C. è eletto pontifex, l’anno seguente tribuno militare. Si stava legando, intanto, sempre di più, a Crasso, sia per motivi finanziari, sia per vicinanza politica alla classe degli equites. Proprio grazie all’appoggio di Crasso, che nel 70 è console insieme a Pompeo, è eletto pretore per il 69 a.C. Nello stesso anno muore, anziana, la zia Giulia, che era stata moglie di Mario. Cesare ne pronuncia l’elogium funebre dai rostri, in foro. Era questa un’antichissima tradizione romana, praticata dalle famiglie più nobili, che serviva a cementare i legami della gens e a sottolineare i valori morali e civili dei defunti. Durante il funerale, dopo l’elogium, venivano portate in pubblico le immagini dipinte o i calchi di cera degli antenati più prestigiosi della gens. Cesare, in quell’occasione, per la prima volta dopo quindici anni, dopo la damnatio memoriae cui erano stati condannati da Silla, fa sfilare in pubblico anche le immagini di Mario e di Mario il giovane, suscitando nella popolazione pianti e commozione. Quell’episodio, coraggioso, segna una svolta importante nella vicenda pubblica del giovane Giulio Cesare. Ancora in quell’anno un evento gioioso si trasforma in tragedia: l’amata moglie di Cesare muore di parto, lasciandolo vedovo, con la piccola Giulia. Cesare, alla fine dell’anno, parte per la Spagna, dove avrebbe esercitato la carica di questore.
In Iberia, da questore, Cesare si comporta con clemenza e giustizia. A questi anni risale un altro famoso episodio. A Cadice, davanti a un busto di Alessandro Magno, Cesare scoppia in lacrime; agli amici che gliene chiedono la ragione, risponde: “Non vi sembra che ci sia motivo di addolorarsi se alla mia età Alessandro regnava già su tante persone, mentre io non ho fatto ancora nulla di grande?”. Al ritorno dall’Iberia Cesare contrae un nuovo matrimonio, suggerito da Crasso; un matrimonio che avrebbe dovuto gettare un ponte con gli optimates. Cesare sposa infatti Cornelia Pompea, una nipote nientemeno che di Silla. I due non avranno figli e il matrimonio non si dimostrerà affatto felice.
Nel 65 a.C. Cesare ottiene una carica che gli consente di guadagnare ancor più il favore della plebe di Roma: l’edilato. Agli edili erano affidati, oltre che i lavori pubblici, l’organizzazione dei giochi e delle frumentazioni nell’urbe. Cesare sfrutta il mandato, appunto, per allestire una serie di feste e spettacoli, gladiatorii e teatrali, che Roma non aveva mai visto. Il popolo comincia ad apprezzare sempre di più quel carismatico personaggio, che appare bravo amministratore e abile oratore, clemente e incisivo. Cesare inanella un successo dopo l’altro, e i senatori cominciano ad essere preoccupati per la sua ascesa.
Non riescono però a impedire che, alla morte di Quinto Cecilio Metello Pio, la carica di pontifex maximus, la più importante magistratura religiosa di Roma, venga affidata proprio a Cesare. Certamente la votazione era stata influenzata dai denari che Cesare stesso, e Crasso alle sue spalle, avevano elargito a molti senatori. Cesare l’aveva spuntata su molti concorrenti ben più anziani e titolati di lui, primo fra tutti Lutazio Catulo. Ma Cesare era pur sempre, come sottolineò egli stesso, discendente da Venere. Così, ad appena 35 anni, diviene pontefice massimo. Tutto sembra spianato, ormai, per la sua carriera, ma proprio nella seconda parte di quell’anno un’ombra pericolosissima si addensa, di nuovo, sul suo futuro.
La congiura di Catilina era stata sventata, i suoi collaboratori arrestati e, in parte, giustiziati, contro il parere di Cesare; ma, prima ancora dello scontro finale in Etruria, a Roma erano incominciate a circolare voci sul coinvolgimento, nella congiura, proprio di Cesare. Egli stesso, e i suoi amici, avevano smontato faticosamente quelle voci, che certamente potevano avere un fondo di verità: Cesare, molto probabilmente, era stato in qualche modo informato dei piani di Catilina, pur non condividendoli in prima persona.
All’inizio del 62 a.C., in ogni caso, le acque si calmarono: Cesare, nell’estate di quell’anno, pose la sua candidatura alla carica di pretore, e la ottenne. Pompeo, intanto, era finalmente sbarcato a Brindisi di ritorno dall’Oriente: aveva portato alle casse dell’erario ingenti ricchezze e nuove province. Molti sospettavano che avrebbe potuto marciare sull’urbe e farsi dittatore a vita, come Silla. Ma Pompeo era un uomo ‘delle istituzioni’ e fece al senato solamente due richieste: la distribuzione di terre ai suoi veterani e la ratifica dei suoi accordi con i sovrani orientali.