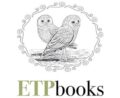Appresa la notizia del passaggio del Rubicone da parte di Cesare, il 17 gennaio Pompeo e decine di senatori fuggono verso Brindisi, per imbarcarsi e raggiungere la Grecia.
Cesare, intanto, occupa una dopo l’altra le città lungo la via Flaminia: Rimini, Pesaro, Fano, Ancona, Arezzo. Il 25 gennaio Pompeo arriva a Brindisi e inizia i preparativi per la partenza. Ma nove coorti delle sue legioni passano dalla parte cesariana. Il 4 marzo i primi a partire per la Grecia sono i consoli Lentulo e Scipione Nasica, con trenta coorti. Il 9 marzo Cesare raggiunge Brindisi e si accampa davanti al porto, ove Pompeo è sulle navi con le coorti a lui fedeli. I due, però, non ingaggiano uno scontro e Cesare lascia partire Pompeo, il 17 marzo, per Durazzo. Decide dunque di tornare a Roma, dopo cinque anni. Vi giunge il 31 marzo. Radunato il senato con i soli membri a lui fedeli, si fa eleggere dictator. Tra i suoi più stretti collaboratori, sceglie come braccio destro per recarsi in Grecia all’inseguimento di Pompeo il giovane Marco Antonio, trentacinquenne, suo nipote di secondo grado e già suo luogotenente in Gallia, allora tribuno della plebe.
A metà aprile Cesare parte per la Spagna: lì infatti si sono asserragliati diversi pompeiani. Mentre Cassio e Trebonio assediano Marsiglia, che cadrà dopo diversi mesi, Cesare raggiunge la Spagna meridionale: il 26 giugno, a Ilerda, cade la prima roccaforte fedele a Pompeo. Contemporaneamente un altro generale cesariano, Gaio Scribonio Curione, raggiunge la Sicilia, dove si è rifugiato Marco Porcio Catone: l’intransigente stoico non parteggia per Pompeo, ma per la respublica, e si oppone all’instaurazione di un potere personale. Curione sbarca nell’isola a maggio, ma Catone parte per l’Africa insieme a diverse coorti fedeli al senato. Il 13 agosto Curione raggiunge le truppe di Catone a Utica, vicino a Cartagine. Lo attacca a sorpresa, ma viene sconfitto e perde egli stesso la vita.
Da agosto a ottobre, Cesare attraversa la Spagna all’inseguimento dei pompeiani più irriducibili: conquista Cordova e Gades, poi torna a Marsiglia. Qui decide di rientrare a Roma, dove il senato a lui fedele lo nomina console per il 48 a.C. Il 22 dicembre, con una mossa a sorpresa, arriva a Brindisi e sbarca a Durazzo, per lo scontro finale.
Nei primi giorni del 48 a.C. uno scontro favorevole a Pompeo illude gli optimates e i conservatori della respublica su una possibile vittoria. Molti giovani romani partono per la Grecia, per dare sostegno a Pompeo, che la propaganda di Cicerone sta dipingendo come un eroe difensore della libertas. Anche la diplomazia è in fermento: proprio l’epistolario di Cicerone ci racconta di tutta una serie di intensi scambi di missive tra i protagonisti del momento. Una soluzione diplomatica è auspicata da tutti, ma non si riesce a raggiungere. Così, dopo alcuni altri scontri, Cesare, a giugno, pone un blocco intorno all’accampamento di Pompeo, sempre nei pressi di Durazzo. All’inizio di luglio, tuttavia, Pompeo riesce a forzare il blocco e si dirige verso la Grecia settentrionale. Si accampa, a fine luglio, nei pressi di Farsalo, in Tessaglia, dove viene raggiunto dalle coorti dell’ex console Scipione Nasica. Pochi giorni dopo Cesare arriva anch’egli nella pianura.
Il 9 agosto del 48 a.C., a Farsalo, si consuma lo scontro finale. I due eserciti sono schierati su tre fronti: ai due lati la cavalleria e al centro la fanteria. Attacca per prima la cavalleria pompeiana sul lato destro. Ma Cesare, che ha previsto la mossa di Pompeo, fa volgere contro di essa anche una parte del centro. L’ala destra è sconfitta, e Cesare ordina ai soldati di irrompere nel centro dello schieramento pompeiano, mentre la sua cavalleria, sull’ala sinistra, accerchia il nemico. Pompeo, resosi conto che la battaglia è perduta, fugge insieme ai suoi generali. Sul campo cadono quindicimila romani a lui fedeli, duecento fra i cesariani.
Pompeo e i suoi si rifugiano sulle coste dell’Asia Minore, poi cercano aiuto, e asilo, presso il sovrano d’Egitto, Tolemeo XIII “Aulete”. Appena sbarcato ad Alessandria, però, il 28 settembre, Pompeo viene prima accolto e poi ucciso. Tolemeo, per accaparrarsi le simpatie del vincitore, vuole offrire a Cesare il suo nemico. Così, quando Cesare arriva ad Alessandria, ai primi di ottobre del 48 a.C., Tolemeo lo accoglie regalandogli la testa imbalsamata di Pompeo. Alla sua vista, però, raccontano le fonti, Cesare piange la fine del suo rivale. Fa decretare per lui onori militari e rompe l’alleanza con Tolemeo. La flotta romana assedia Faro, incendia il porto di Alessandria e, forse, la grande Biblioteca. Entra a questo punto in gioco un altro protagonista di questi decenni: la sorella del sovrano egiziano Tolemeo, la regina Cleopatra, che all’epoca ha ventuno anni, esattamente trenta meno di Cesare. Come si è visto, i Tolemei discendevano per linea diretta dal fondatore della dinastia, Tolemeo I Sotèr, “Salvatore”, con tutta probabilità un figlio che Filippo II di Macedonia aveva avuto, prima di Alessandro Magno, da una nobile macedone. Cleopatra è dunque greca, coltissima, abile e disinvolta. Già da tempo ha concepito l’idea di sbarazzarsi del fratello per regnare da sola sull’Egitto. Cesare gliene offre l’opportunità: in poco tempo, esautorato Tolemeo Aulete, Cesare si intromette nelle faccende egiziane, stipulando un accordo con Cleopatra. I due, nel frattempo, hanno probabilmente già stretto una relazione, dalla quale sarebbe nato, appena un anno dopo, il primo e unico figlio maschio di Cesare.