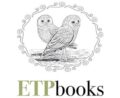Nelle elezioni degli ultimi anni, dal 69/68 a.C. in poi, erano state sempre figure molto vicine a Pompeo e a Crasso ad ottenere la carica di console. Non era mancata, certamente, un’opposizione. Tra chi aveva provato a contrastare lo strapotere dei pompeiani e della nobilitas vi era un giovane, allora quarantenne, proveniente da una delle famiglie più nobili e antiche di Roma, la gens Sergia, discendente, si diceva, addirittura da un compagno di Enea. Il suo nome era Lucio Sergio Catilina.
Catilina, diversi anni prima, appena ventenne, si era distinto tra i più facinorosi seguaci di Silla, anche durante le proscrizioni. Dopo la dittatura sillana, tuttavia, si era sempre più avvicinato alle posizioni dei populares, rispolverando l’idea radicale di riforme agrarie e fiscali, secondo alcuni perché molto indebitato.
Dopo aver ricoperto le cariche di edile (nel 70 a.C.), pretore (nel 68) e propretore (in Africa, nel 67), aveva intenzione nel 66 a.C. di porre la sua candidatura alle elezioni per il consolato del 65. Molti senatori, tuttavia, poiché già circolavano le voci del suo progetto di nuova legge agraria, sulla scorta di quelle dei Gracchi, e addirittura di un programma di abolizione dei debiti, fecero di tutto per bloccare la partecipazione di Catilina alle elezioni. Fu accusato di corruzione per l’amministrazione in Africa e, poiché imputato, non poté porre la sua candidatura. Il processo fu trascinato, con pretesti burocratici, fino a tutto il 65 a.C., e Catilina non poté partecipare neanche quell’anno alle elezioni per il consolato.
È in questa situazione incandescente che, per tutto il 64 a.C., Catilina, concluso finalmente il processo con un’assoluzione, inizia la sua campagna elettorale. I suoi discorsi mirano a screditare la nobilitas e il senato, e a raccogliere consensi tra i populares e gli equites. La maggioranza dei senatori comincia ad avere serie preoccupazioni e tenta il tutto per tutto con una mossa ‘a sorpresa’. Accanto ad un altro candidato ‘sicuro’, il nobile Gaio Antonio, a contrastare l’elezione di Catilina, ormai quasi certa, è indicato un politico ‘nuovo’, che si è distinto proprio per la sua lotta alla corruzione, e che ora il Senato sceglie a difensore dell’ordine costituito e dell’equilibrio sociale: Marco Tullio Cicerone.
Le vicende di questo anno cruciale ci sono raccontate da numerose fonti antiche: la monografia sulla Congiura di Catilina di Sallustio e le orazioni di Cicerone Contro Catilina, due testimoni oculari; poi la Vita di Cicerone di Plutarco e le Storie di Cassio Dione e altri. Quasi sempre gli autori sono ostili a Catilina: lo storico moderno, dunque, deve fare non pochi sforzi per separare i dati reali dalle notizie montate ad arte per screditare lo scomodo personaggio.
In un clima tesissimo, ai primi di giugno del 64 a.C., Catilina raduna nella sua casa romana i suoi fedelissimi e rivolge loro un discorso di fuoco, stando alle parole che riporta Sallustio: “Via via che passano i giorni, il mio animo si infiamma al pensiero del futuro che ci attende, se non rivendichiamo la nostra libertà. Da quando la repubblica è caduta in balia di un manipolo di potenti, a loro versano i tributi i re e i tetrarchi, a loro pagano imposte i popoli e le nazioni; gli altri, noi tutti, coraggiosi, onesti, nobili e non nobili, non siamo divenuti che volgo, senza autorità, senza prestigio. […] Fino a quando saremo disposti a sopportare ciò? Ora abbiamo la vittoria in pugno […] Servitemi di me come capo e come gregario: il mio cuore, il mio braccio non vi verranno meno. Queste cose, spero, le farò con voi quando sarò console, a meno che qualcosa non vada storto, e voi siate disposti più a servire che a comandare”.
È l’annuncio di un ‘piano B’, nel caso in cui, per la terza volta, a Catilina fosse stato impedito il consolato.
Pochi giorni dopo si tengono le elezioni. Catilina ha fatto arrivare nell’urbe migliaia di suoi clientes, ma le forze della nobilitas e il timore, tra gli equites, di riforme troppo radicali, spostano molti voti proprio su Cicerone. Altri brogli, probabilmente, fanno il resto e Catilina è sconfitto. Per il 63 a.C. sono dunque eletti Gaio Antonio, candidato sicuro del senato, e Cicerone.
È a questo punto che Catilina decide di passare all’illegalità, ordendo una congiura contro il potere del senato. Tutta la fine del 64 a.C. è dedicata ai preparativi. Il suo piano è quello di uccidere i consoli appena entrati in carica, allestire un esercito ‘personale’ in Etruria (dove lo appoggiano l’amico Manlio e un altro congiurato, detto il Fiesolano) e marciare sull’urbe.
Entrati in carica Cicerone e Antonio, Catilina rimanda l’attentato per aspettare l’arrivo di nuove forze in Etruria. Si progetta di eliminare i consoli ai primi di marzo, ma Catilina rimanda ancora la decisione finale: pone la candidatura a console per il 62, forse perché vuole dare un’ultima opportunità ai senatori che gli sono ostili. Catilina sembra ancora una volta non avere rivali, ma i brogli elettorali, certamente organizzati anche da Cicerone, gli bloccano la strada. Di nuovo sconfitto e umiliato, Catilina decide di attuare senza indugi il suo piano. Dopo essersi assicurato la preparazione dell’esercito in Etruria, convoca i congiurati e fissa le date per eliminare i consoli e dare il via alla rivolta. Siamo ai primi di novembre del 63 a.C. Nel frattempo, però, il progetto della congiura viene svelato. Uno dei congiurati, Quinto Curio, è incalzato dalla sua amante, Fulvia, che vuole sapere se sono vere le voci di un colpo di mano progettato da Catilina. Curio le racconta i piani in dettaglio. Non sa, però, che Fulvia è stata ‘assoldata’ proprio dal nemico giurato di Catilina, cioè Cicerone. Appena compresa la gravità della situazione, Fulvia si precipita a casa di Cicerone, rivelando tutto. È la notte tra il 6 e il 7 novembre del 63 a.C. Cicerone è informato da Fulvia dell’attentato imminente: il cavaliere Gaio Cornelio e il senatore Lucio Vargunteio, alle prime luci dell’alba, si presenteranno da lui con una scusa, per assassinarlo. Cicerone chiama i militari di guardia e la mattina del 7 novembre, quando i due congiurati si presentano a casa del console, trovano i militi ad arrestarli. Il panico si diffonde in senato e in città. La mattina dell’8 novembre Cicerone convoca il senato nel tempio della Concordia. Catilina si presenta ad ascoltare le comunicazioni del console. Qui Cicerone pronuncia un discorso (quello che per noi è la Prima Catilinaria) con il quale rivela la congiura e accusa pubblicamente Catilina di attentare alla res publica. Catilina lascia il senato minacciando il console e, nella notte, fugge da Roma verso l’Etruria.
Il 9 novembre Cicerone pronuncia un altro discorso in senato: accusa per nome e cognome tutti i congiurati e rivela che Catilina si trova in Etruria con un esercito illegale. Tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre, grazie alla complicità di alcuni capi gallici Allobrogi, assoldati da Cicerone per fare il doppio gioco con i congiurati, fingendo di appoggiare la rivolta, Cicerone riesce ad entrare in possesso di alcune lettere firmate da alcuni dei congiurati: è la prova schiacciante della colpevolezza. In cinque sono catturati e rinchiusi nel carcere mamertino. Il 3 dicembre si svolge in senato una seduta infuocata, raccontata in dettaglio ancora da Sallustio. All’ordine del giorno Cicerone pone la condanna a morte dei congiurati, senza appello al popolo: un fatto enorme, come l’attentato alla patria, richiede la sospensione di alcune garanzie giuridiche, come, appunto, il ricorso alla clemenza del popolo in casi di condanna (provocatio ad populum). Il senato è a lungo incerto, alcuni si dichiarano favorevoli alla condanna, ma senza sospendere la garanzia dell’appello: tra questi, a intervenire con un lungo discorso improntato alla moderazione, è Gaio Giulio Cesare, da poco entrato nella vita politica, benché maturo di età. Ma a scendere in campo a favore della condanna senza appello è Marcio Porcio Catone, pronipote del famoso Censore del II sec. a.C., che spinge i senatori ad accettare la proposta di Cicerone. La notte stessa il console fa eseguire la condanna: i cinque sono strangolati nel carcere.
Due legioni, nel frattempo, stanno raggiungendo l’Etruria, dove Catilina, Manlio e il Fiesolano aspettano con le loro truppe. Le legioni sono al comando di Marco Petreio, pompeiano fedele, che nei primi giorni del gennaio del 62 raggiunge lo schieramento di Catilina e ingaggia una sanguinosissima battaglia. Così narra Sallustio: “I veterani romani premono aspramente sui catilinari, ma quelli resistono senza paura. Lo scontro è violentissimo. Catilina si prodiga in prima linea, soccorre quelli che si trovano in difficoltà, provvede a tutto, spesso colpisce il nemico, da valoroso soldato e comandante efficiente. Marco Petreio, nel vederlo battersi così accanitamente, lancia la coorte pretoria al centro dello schieramento nemico, poi attacca ai fianchi. Manlio e il Fiesolano cadono tra i primi, con le armi in pugno. Catilina, come vede i suoi in rotta, memore della sua stirpe e dell’onore di un tempo, si getta nel folto della mischia e qui cade combattendo. Finita la battaglia, solo allora avresti potuto davvero vedere quale fosse l’ardire, la forza d’animo dei catilinari: caduti, coprivano tutti il posto in cui erano stati schierati, e tutti colpiti al petto. Catilina fu trovato lontano dai suoi, in mezzo a cadaveri dei nemici. Respirava ancora un poco: nel volto, l’indomita fierezza che aveva da vivo”.