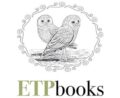Per tutta la fine del 48 e l’inizio del 47 a.C. Cesare è ad Alessandria, con Cleopatra. Deve anche far fronte a una rivolta dei cittadini egizi, che non vedono di buon occhio né la nuova regina né il suo protettore romano. In un’occasione estrema, Cesare è costretto persino a mettersi in salvo a nuoto nel canale di Alessandria, salvando con una mano i suoi nuovi Commentarii de bello civili, in cui ha descritto l’anno di guerra con Pompeo: riuscirà a farli circolare nell’urbe, per alimentare il suo consenso.
Iniziano, tuttavia, in quell’anno una serie di nuove campagne militari nelle quali Cesare, e i suoi generali, sono costretti a combattere su vari fronti, in tutto il Mediterraneo, per sconfiggere gli ultimi fedelissimi di Pompeo e del senato. In estate Cesare lascia l’Egitto e si dirige nel Ponto: qui Farnace II, che era stato alleato di Pompeo, marcia contro la provincia romana. Cesare lo sconfigge sul Bosforo, con una campagna lampo passata alla storia per il laconico dispaccio inviato al senato – veni, vidi, vici, “venni, vidi, vinsi” – e fa ritorno a Roma in ottobre. Di qui riparte immediatamente per l’Africa: nei dintorni di Cartagine, infatti, si sono radunati i più importanti generali di Pompeo, sotto la guida di Catone: Labieno, Scipione Nasica, Gneo e Sesto, i due giovani figli di Pompeo (e Metella). Il 28 dicembre del 47 a.C. Cesare è in Africa. Questa spedizione ci è narrata da un anonimo resoconto, intitolato Bellum Africum, scritto probabilmente da uno dei generali cesariani: è una testimonianza straordinaria della guerra vista da un soldato vero, con tutti gli episodi cruenti della vita militare; inoltre, è scritta in un latino piuttosto popolare, ricco di espressioni idiomatiche e assolutamente espressivo.
Dopo vari scontri episodici, la battaglia decisiva avviene a Tapso, vicino a Utica. Dopo due giorni di sanguinosissimi combattimenti, Cesare e Marco Antonio hanno ragione dei pompeiani: Scipione Nasica e Catone si danno la morte per non cadere nelle mani dei vincitori. Catone diverrà famoso, e icona della libertà repubblicana contro la tirannide, come Catone “Uticense”. I figli di Pompeo, Gneo e Sesto, si rifugiano in Spagna. Il 25 luglio Cesare può fare ritorno a Roma: celebra uno dei trionfi più imponenti della storia. Molti cittadini, però, fanno notare che si tratta del primo trionfo di Romani su Romani. Da agosto a ottobre si susseguono altri quattro trionfi, ognuno per le campagne militari esterne di Cesare. Con lui è anche Cleopatra, che ha portato dall’Egitto quantità enormi di grano da distribuire alla popolazione dell’urbe, e decine di elefanti e fiere selvagge per gli spettacoli. Cleopatra ha fra le braccia il figlio maschio di Cesare, che, tuttavia, continua ad essere legalmente sposato con Calpurnia, in una situazione che certamente imbarazza non solamente la parte più tradizionalista dell’opinione pubblica romana. Alla fine di quell’anno, Cesare distribuisce 24mila sesterzi ad ogni suo veterano, e in più un appezzamento di terra. Ad ogni cittadino di Roma vengono donati 100 sesterzi e sono cancellati tutti i debiti inferiori ai 1000 sesterzi. Avvia la fondazione di nuove colonie, dove sono inviati oltre 80mila nullatenenti o agricoltori impoveriti. In quello stesso ottobre del 46 a.C., su proposta di Marco Antonio, Cesare è nominato per la terza volta console e dittatore per dieci anni. È riuscito a tenere lontane da Roma e dall’Italia le lotte civili, al contrario di quel che era avvenuto con Mario e Silla. Cesare ha ormai Roma in pugno, ma l’ultima resistenza repubblicana non è ancora domata.
All’inizio del 45 a.C. Cesare deve recarsi di nuovo in Spagna: i figli di Pompeo, Gneo e Sesto, e il fedele Labieno, l’ultimo generale pompeiano, hanno riorganizzato un grande esercito e minacciano di calare in Italia. Il 17 marzo si svolge lo scontro decisivo a Munda: Labieno cade valorosamente sul campo; Gneo Pompeo si dà la morte, solo Sesto riesce a sfuggire in Sicilia. Cesare torna a Roma, in estate, e ottiene il suo quarto consolato. Tutte le resistenze sono ormai vinte. Cesare può dare inizio alla sua politica di riforma della respublica:
– viene aumentato il numero dei senatori, che passano a 900, e di tutte le magistrature;
– agli abitanti della Gallia Cisalpina (attuali Piemonte, Lombardia e Veneto) viene concessa la cittadinanza romana;
– è avviato un censimento per conoscere meglio la popolazione romana;
– viene attuata una riforma del calendario, che rimarrà in vigore fino al XVI secolo;
– è finanziata la costruzione di un nuovo Foro sotto la fiancata destra del Palatino, e di una grande basilica accanto al tempio di Castore e Polluce;
– viene riorganizzato l’esercito con la dotazione di reparti di iuvenes e di veterani;
Alla fine del 45 a.C. Cesare si fa eleggere console per la quinta volta, accanto a Marco Antonio.
Nel gennaio del 44 a.C., come primo atto ufficiale, annuncia un’imponente spedizione contro i Parti, per vendicare la sconfitta di Crasso e recuperare le insegne romane di cui il nemico si è impossessato.
Il 14 febbraio il senato, su proposta di Antonio, lo nomina dittatore a vita. Il giorno successivo Antonio lo saluta rex mentre fa un discorso dai rostri, porgendogli una corona d’oro, ma Cesare rifiuta l’epiteto e dedica la corona d’oro alla statua di Giove Ottimo Massimo Capitolino. Nell’aria, però, una radicale riforma della respublica è ormai chiara a tutti. È il segnale per chi, come molti senatori conservatori, sta tramando nell’ombra in una congiura. Secondo molte fonti, è Cicerone ad ispirare un colpo di mano. Secondo altre, un generale di Cesare, Gaio Cassio Longino, deluso per la predilezione di Cesare nei confronti di Marco Antonio, ordisce il complotto. Ai congiurati si unisce persino Decimo Giunio Bruto, che è stato luogotenente cesariano in Gallia e in Spagna, e che è discendente del famoso Bruto liberatore dai Tarquini e primo console di Roma.
Un indovino aveva predetto a Giulio Cesare di stare attento alle idi di marzo, il 15 del mese. La cosa era di dominio pubblico, e i congiurati fissano la data dell’agguato proprio per quel giorno. Le fonti raccontano che per tutta la settimana precedente si verificano presagi nefasti a Cesare e in tutta Roma: rumori notturni, fuochi celesti, nati deformi nelle mandrie del dittatore e in tutto il Lazio. La mattina del 15 marzo del 44 a.C. Calpurnia sveglia Cesare di soprassalto: ha fatto un incubo, ha sognato di tenere il marito morto fra le braccia. Cesare la rassicura, indossa la toga consolare e si avvia, senza scorta, in Senato. Qualcuno gli porge un messaggio sigillato, pregandolo di leggerlo prima possibile: contiene la rivelazione della congiura. Ma Cesare non può leggerlo a causa della folla festante che si accalca lungo la strada, per salutarlo e chiedergli suppliche e favori. Davanti al senato lo aspetta Antonio. Cesare vuole entrare con lui in senato, ma Bruto prega Antonio di fermarsi con lui ancora qualche istante a discutere una faccenda importante. Cesare dunque entra da solo, si siede sul suo seggio e viene subito circondato dai congiurati, che fingono di volergli sottoporre alcuni atti urgenti. Ad un segnale convenuto, il primo a colpire Cesare con un pugnale è Servo Sulpicio Casca: la mano, tremante, ottiene solo una leggera ferita al collo. Ma è un attimo: Cesare tenta una reazione con il suo pugnale personale, ma viene aggredito da ogni parte.
Racconta Svetonio: “Quando si accorse che lo aggredivano da tutte le parti con i pugnali nelle mani, si avvolse la toga attorno al capo e con la sinistra ne fece scivolare l’orlo fino alle ginocchia, per morire più decorosamente. Così fu trafitto da ventitré pugnalate, con un solo gemito, emesso sussurrando dopo il primo colpo. Cadde ai piedi della statua di Pompeo, e rimase lì per un po’ di tempo, privo di vita, mentre tutti fuggivano, finché, caricato su una lettiga, con il braccio che pendeva fuori, fu portato a casa da tre schiavi”.